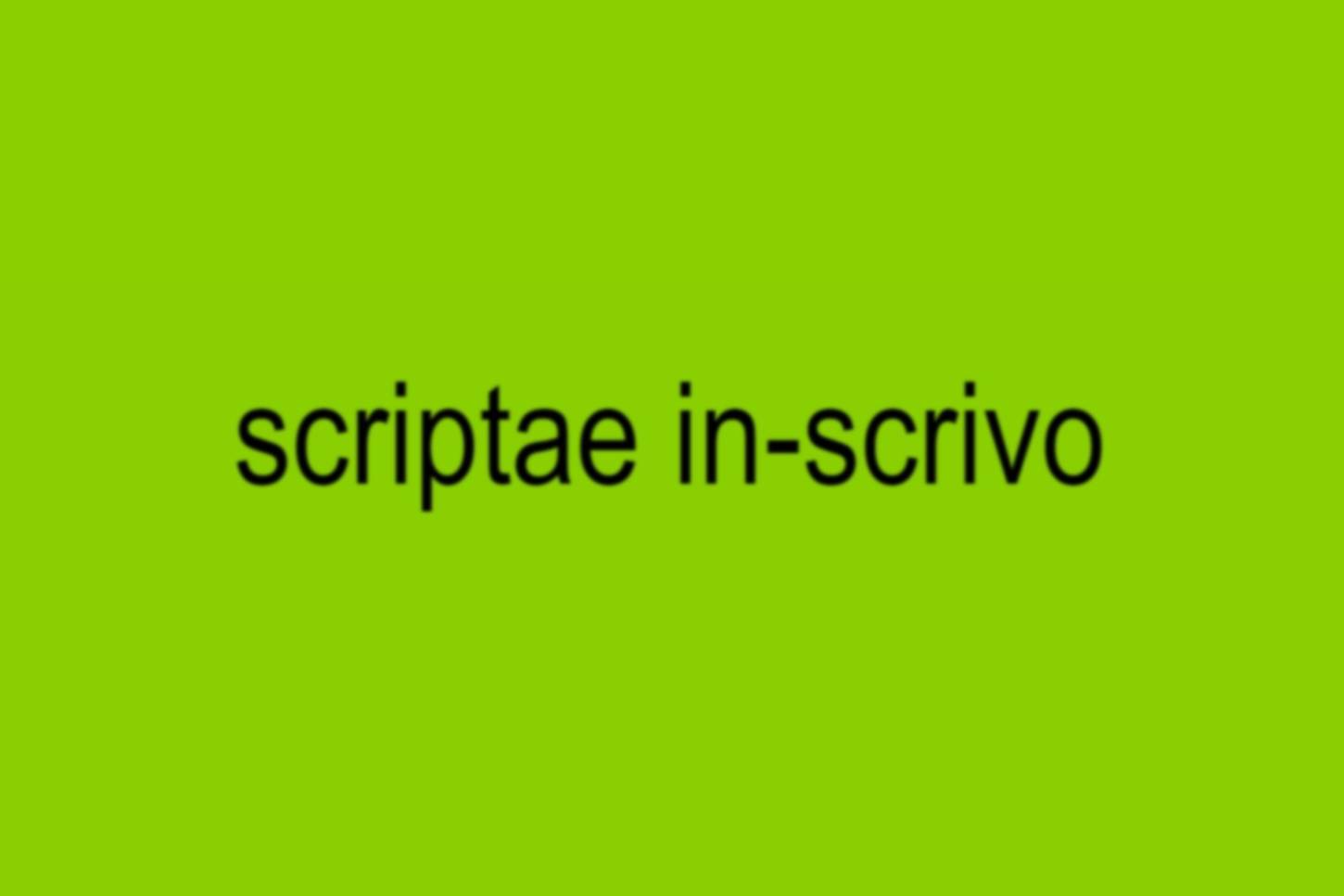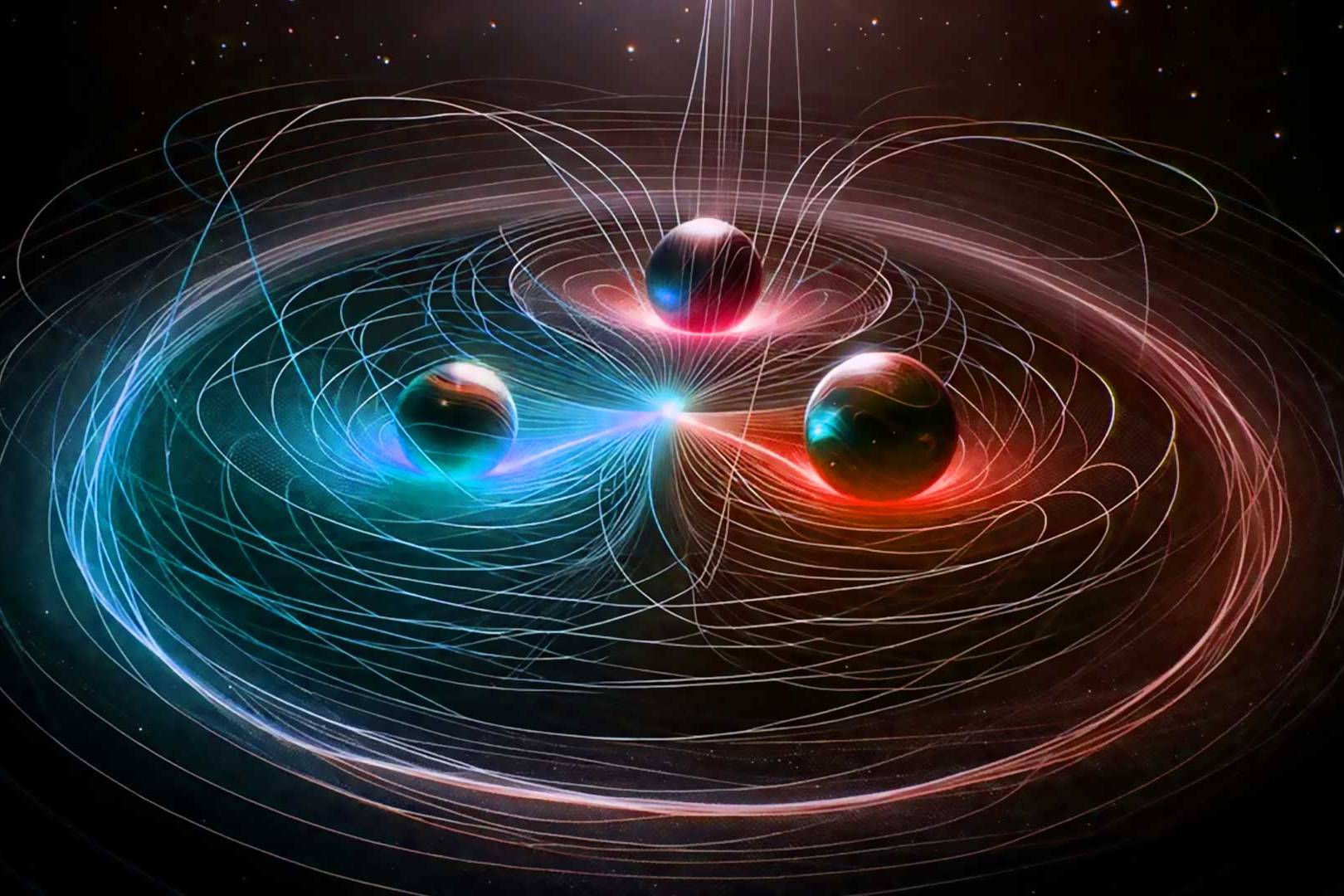La letteratura connessa all’inclusività ha una netta predominante sul genere. Le ragioni sono molteplici e affrontate da numerose esperte (e non sovraestendiamo), resta comunque il dato che quando parliamo di inclusione in azienda pensiamo rapidamente a superare la disparità di genere. Anche attraverso il linguaggio.
Ma non oggi.
C’è un forte bias cognitivo, anche all’interno delle aziende multiculturali, riguardo ad una presunta superiorità locale, che si esprime attraverso semplificazioni: – il nostro modo di fare le cose, il miglior cibo del mondo, le nostre tradizioni. Da un punto di vista teorico nessun orgoglio per il proprio mina l’apertura all’altrui, spesso però si attivano modalità di Groupthink in cui i partecipanti di minoranza non hanno più spazio per esprimere le loro considerazioni, con esiti – volendo guardare solo l’orticello aziendale – di grande inefficienza. La provenienza diversa delle persone che lavorano, che hanno quindi esperienze, vissuti, religioni differenti genera spesso crash culturali che se non prevenuti possono danneggiare clima e percezione aziendale.
Può il linguaggio inclusivo entrare come un miglioramento di questo problema?
Una filiale veneta di una grande compagnia assicurativa ci ha commissionato un’audit dei propri strumenti di comunicazione corporate, e una revisione delle metodologie di comunicazione interna, con un percorso formativo per comunicare in modo inclusivo.
Come mai hanno richiesto il nostro lavoro? Interessante storia.
Poche settimane prima di contattarci l’azienda organizzava una giornata di teambuilding, costruita dal manager con molto impegno. Un pomeriggio di laboratorio di cucina, per collaboratori e collaboratrici, che avrebbero preparato il cibo insieme e poi cenato, con l’occasione delle festività natalizie.
La comunicazione interna di questa attività, una mail con un invito che il manager aveva realizzato personalmente per mantenere l’effetto sorpresa, riportava la frase “prepariamo insieme la Cena di Natale”.
Dal punto di vista di chi ha scritto, anche se non esplicitamente espresso, è evidente che la preparazione della Cena di Natale con le persone dell’ufficio non sia un momento di celebrazione religiosa della festa cristiana; nessun partecipante si aspetta di pregare, o di partecipare a qualcosa di sacro; è una cena – ricca – in occasione di un periodo di festeggiamenti. Chi scrive non pensa di doverlo precisare, perché per chi legge è evidente. Sempre?
Il punto di vista di chi ha scritto e della maggioranza di chi ha letto non è però l’unico punto di vista.
Due dipendenti hanno infatti trasferito quella comunicazione nel proprio asset culturale e hanno visto quel momento come una celebrazione di una festa di una religione a cui non appartengono e non vogliono essere associate. Avrebbero partecipato al team building, come sempre hanno fatto in precedenza, ma non hanno partecipato a quella occasione. Il manager era costernato e incredulo, perché era fortissima in lui l’evidenza del fraintendimento, eppure non era riuscito a colmare quello spazio interculturale. Dall’altro lato c’erano delle persone per cui non era proprio possibile fare quel passo, che sentivano errato.
Può il linguaggio inclusivo costituire un miglioramento di questo problema?
Non sembra una risposta difficile adesso.
È entusiasmante lavorare con la voce delle aziende, creando qualcosa che le rappresenti nel dettaglio, non facendo semplici trucchi magici con gli asterischi.
Non è soltanto la comunicazione verso l’esterno a richiedere l’inclusività, perché non si tratta di languagewashing; è la comunicazione interna, il modo con cui ascoltiamo chi lavora con noi a costituire per l’azienda credibilità e valore.
Si può fare, facciamolo.
Related Posts
13 Settembre 2024
brat, o perché scrivere senza maiuscole
Non c’è bisogno di appartenere alla Gen Z né di ascoltare musica pop:…
14 Agosto 2024
Cantare la disarmonia
Essere green, eco e sostenibili. Stare woke: consapevolə, attentə e attivə.…
24 Luglio 2024
Politically correct e linguaggio inclusivo non sono la stessa cosa
Politicamente s-corretto “Eh, ma non si può più dire niente”, “Mi sa che…